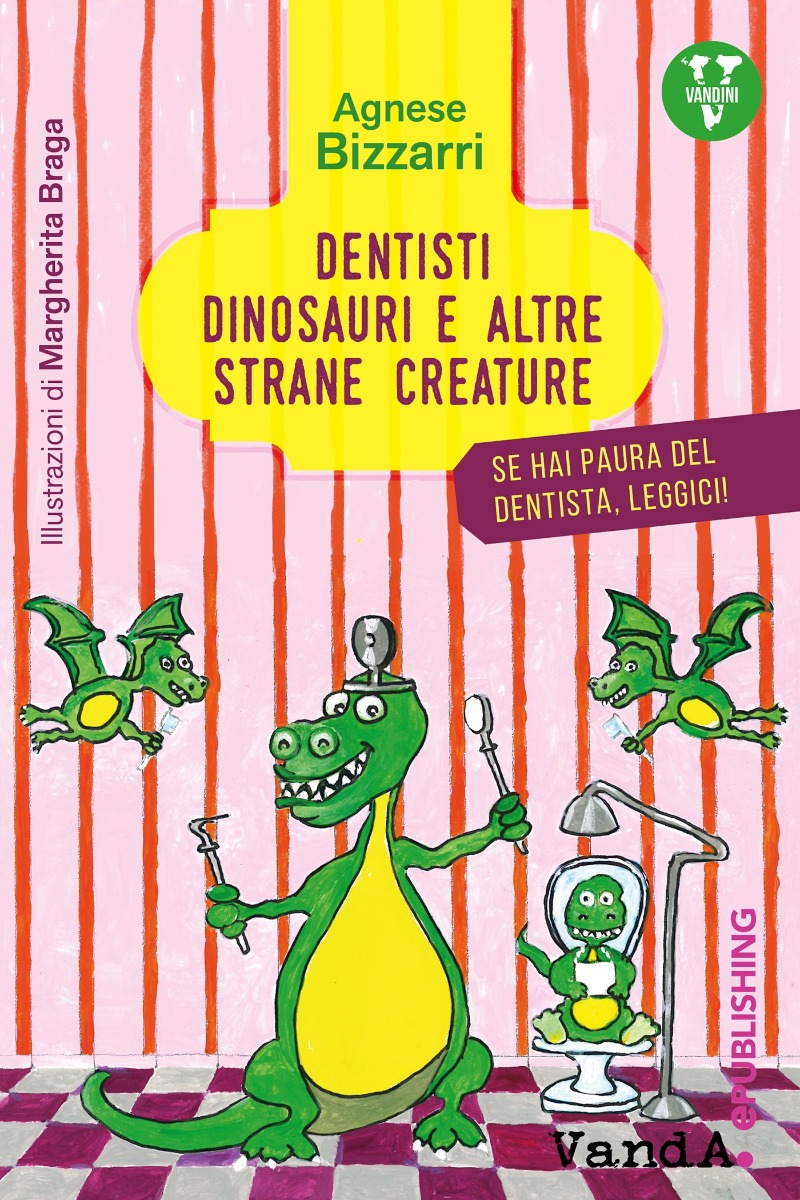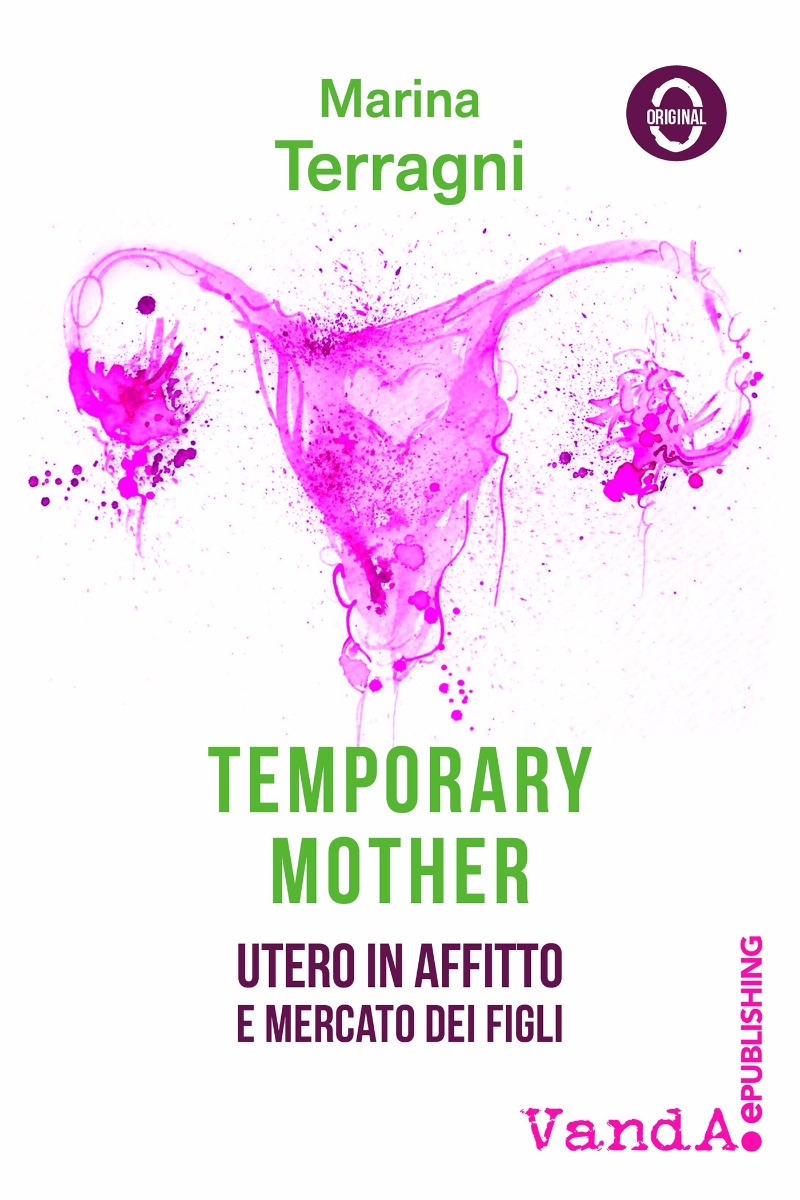«La pietra e la luce fanno Siracusa una città-scultura»

di Annalisa Stancanelli (La Sicilia, 28 dicembre 2016)
– Interrompiamo il lavoro di Giuseppina Norcia mentre è alle prese con la fase finale di un romanzo a cui ha lavorato intensamente negli ultimi 3 anni e che attinge a un “grande mito” ma di cui non vuole svelare nulla.
Interrompiamo il lavoro di Giuseppina Norcia mentre è alle prese con la fase finale di un romanzo a cui ha lavorato intensamente negli ultimi 3 anni e che attinge a un “grande mito” ma di cui non vuole svelare nulla.
Che senso ha la scrittura nella sua vita? Quale la molla che la spinge a narrare? «È una forza irresistibile, non governabile. Penso spesso al grande mito di Sherazade che ne Le mille e una notte narra storie per salvare la sua città, ma anche per curare il cuore malato del suo re. E così facendo salva se stessa. Credo che la letteratura abbia un grande potere salvifico, ma non può farlo se non in una dimensione di costruzione armonica e di piacere in cui alla fine di ogni storia desideriamo sentirne un’altra».
Immaginava il successo del suo libro “Siracusa, dizionario sentimentale di una città”? «Era un mio desiderio, perché a quel libro ho dedicato ben 7 anni, densi di studio, emozioni, viaggi sentimentali tra i segreti di questa città, ma il successo che ha avuto ha superato ogni mia aspettativa. Il dono più grande è stato sentire quanto il dizionario abbia toccato il cuore delle persone; qualcuno lo ha definito un compagno di viaggio, o una cura per l’anima, dando un immenso significato agli sforzi che la scrittura ha richiesto».
Quale la soddisfazione più grande? «Non saprei ascriverla a un episodio in particolare. Posso dire che ogni volta che un conflitto “muta colore” trasformandosi in occasione di dialogo, che ritrovo lo stupore, che vedo cadere il muro di un pregiudizio, di uno stereotipo, provo una grande gioia. A ciò mi dedico tramite la mia vita personale ma anche con il mio lavoro, con i laboratori sulla tragedia e sulla trasformazione creativa dei conflitti che svolgo con i bambini e adolescenti, e tramite gli incontri con le persone, nelle scuole, a teatro, nelle piazze. Spesso è proprio da lì, dalle domande, dagli sguardi che si accendono durante un racconto che traggo l’ispirazione».
Cosa vuol dire narrare la storia di Siracusa? «Il rapporto con la storia di Siracusa segue proprio questo andamento creativo, piuttosto lineare. Di Siracusa amo la stratificazione, la luce la pietra così facile da scavare che la rende quasi una città-scultura, la sua vocazione a essere un immenso scrigno di storie».
I suoi percorsi di studio come hanno segnato la sua vita? «Non sono mai riuscita a scindere i percorsi di studio dalla vita stessa. È piuttosto l’intimo intreccio tra le 2 ad aver tracciato il percorso. Ad esempio, sulla letteratura ho imparato molto dai librai, figure preziose e irrinunciabili. Nessun supermercato del libro, per quanto ben fornito, potrà essere paragonato a un librario che ama i libri, che li consiglia, li presenta come amici cari o quasi li prescrive, come una terapia. Certo, poi ci sono le lezioni, o i docenti indimenticabili».
C’è una relazione tra cultura e felicità? «Assolutamente sì! Il Sutra del Loto – il meraviglioso insegnamento su cui si basa la pratica buddista che ho abbraccciato 17 anni fa – parla della felicità come “del desiderio che esiste da sempre in fondo al cuore”. Ogni istante di vita ha un potenziale infinito, sta a ognuno di noi riconoscerne l’immenso valore e realizzare la missione che lo rende unico».
Quali filosofi dovrebbero conoscere tutti e perché? «Personalmente amo molto Platone, i suoi dialoghi quasi teatrali, la sua capacità di creare i miti, l’immagine indimenticabile che ci trasmette del suo maestro Socrate. Credo che la relazione maestro-discepolo sia una delle più nobili, un tesoro inestimabile. Per questo dedico sempre le mie vittorie al mio maestro Daisaku Ikeda, filosofo, maestro buddista, costruttore di pace, che è per me costante fonte di ispirazione».
Qual è il mito che la emoziona di più? Oggi i miti hanno un senso? «Sono intensamente legata ad Antigone, un personaggio che torna ciclicamente nella mia vita, spesso in momenti importanti. Il mito attinge alla sorgenete della vita, quindi ha una forza inesauribile che lo rende insieme antico e contemporaneo. Il grande studioso Kàroly Kerényi lo definiva un tessuto senza orli, rendendo perfettamente la sua natura magica e labirintica. Il mito è sempre stato nella mia vita, da quando mio padre mi raccontava l’Odissea, come un cantastorie, spesso agganciando le storie a luoghi di grande fascino, come il nostro mare, o l’Etna. E a mia volta amo raccontarlo sia agli adulti sia ai ragazzi, tramite il raccontarlo sia agli adulti sia ai ragazzi, tramite il racconto orale o con la scrittura, come nel libro L’Isola dei miti. Anche il romanzo che ho appena finito attinge a un grande mito, per scavare nei grandi temi del destino, della vita e della morte, dell’eroismo. Delle ragioni, se ve ne siano, per cui può scoppiare un aguerra. Trovo che il racconto mitico sia uno specchio straordinario con cui narrare la contemporaneità. Tra le storie poco note mi appassiona moltissimo la vicenda di Achile a Sciro,tramandata, nei suoi particolari, dal poeta latino Stazio. Secondo questa versione dl mito, Teti avrebbe cercato di salvare suo figlio dalla guerra di Troia nascondendolo nell’isola di Sciro, travestito da donna per non farlo partire. Una versione completamente diversa dal grande guerriero omerico, ma altrettanto affascinante. Dopotutto Achille è un figlio del mare, proteiforme come sua madre…».
Il teatro classico: il suo ruolo oggi e che peso ha avuto nella sua vita? «Il teatro classcio è vita e passione. Ricordo ancora la prima volta che ho assistito a una rappresentazione classica al teatro greco di Siracusa: era il 1986 e mettevano in scena Le Supplici di Euripide, con il titolo Le Madri. Ricordo Elena Zareschi, quelle voci potenti di madri che piangono i figli morti in guerra, il silenzio religioso degli spettatori nella cavea, la presenza complice e affettuosa di mia zia Patrizia che mi aveva portata con sè a quel rito iniziatico. Fu una folgorazione. Per me il Dramma Antico è sempre la casa in cui tornare, una fonte di ispirazione, di studio e di passione. Credo che il suo ruolo oggi sia fondamentale, per la profondità di pensiero e la bellezza di cui è portatore, ma abbiamo la responsabilità di tutelarlo, non indulgendo a logiche di puro intrattenimento, nè al contrario chiudendolo di nuovo nella torre d’avorio in cui è stato segregato per secoli».
Quali opere non mancano nella sua biblioteca? «I tragici, l’epica, i lirici greci sono i miei preferiti. devo molto alla Yourcenar, a Gesualdo Bufalino, a Italo Calvino. Ho amato molto Ariosto, la sua ironia, non potrei rinunciare a Montale e a Ungaretti, o a quel sogno di Grecia che è Ritsos».
Quale il suo rapporto con la città e i siracusani? «È un rapporto dinamico, in costante evoluzione. Lo vivo con un’intensità quasi assoluta, come fossi cittadina di una polis antica, eppure ho trascorso, e potrei trascorrere, molti anni altrove. Molti capitoli del libro che ho dedicato a questa città sono stai scritti in anni difficili, in cui, pur vivendoci, mi sentivo quasi in esilio. È stat un’esperienza preziosa, perchè anzichè fuggire da Siracusa ho desiderato attingerealla sua luce, come chi cerchi l’acqua nel deserto. E alla fine l’ho trovata. A ogni passo sentivo che cambiavo qualcosa di me stessa e dunque della relazione con il luogo. il punto di svolta è stato riuscire asentirmi libera dai consensi, dall’opinione degli altri».
Com’è vista Siracusa dagli stranieri? «Qualche volta rimango a osservarli, ammiro lo sguardo sognante ed estatico dei viaggiatori, ma anche la libertà con cui vivono questo luogo molti stranieri, quando vi si trasferiscono. Ne amano la storia, la stratificazione, qualche volta vivono con una punta di esotismo le nostre tradizioni e proprio in virtù di ciò ci aiutano a non dimenticarle, a rivitalizzarle. Grazie a miei amici e studenti statunitensi ho imparato molto sul fascino che esercitano i luoghi del mito e sula possibilità di giocare, nel senso più alto, con la tradizione classica».
Quale musica la fa pensare a Teatro Greco? «Al trameno mi fa pensare a un adagio di Mozart, nei mezzogiorni assolati sento un suono di flauti e timpani, in certi giorni liquidi di primavera pensopiuttosto alle melodie di Satie o di Debussy».
Nel corso dei suoi incontri letterari quali storie hanno riscontrato più attenzione? «A suscitare attenzione non sono in genere le storie in sè ma il modo in cui le raccontiamo».
Giuseppina Norcia ha 43 anni, è sposata, ama la cucina, il mare e anche i racconti intorno al fuoco. Si definirebbe un’entusiasta della vita. Eclettica e dinamica è impegnata su diversi fronti, forse perchè ama il nomadismo culturale – ha detto – la possibilità di confrontarsi con persone ma anche ambienti diversi. Da qualche anno tiene corsi di drammaturgia antica nell’Accademia d’Arte del Dramma Antico: si tratta di un laboratorio basato sul dialogo, una fucina di idee in cui, con i suoi allievi-attori, esplora e “interroga” le opere dei grandi tragici. Da qualche giorno ha anche intrapreso un progetto di divulgazione e valorizazione del meraviglioso patrimonio culturale di Siracusa.